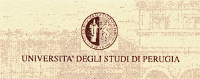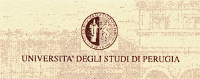| |
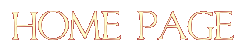

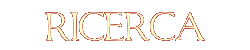



Cliccare sull'immagine per ingrandirla:




|
|
|
L’AREA DEL FORO
La tradizione erudita locale, moderna e
contemporanea, è concorde nel localizzare il foro entro l’ampio spazio che
si estende ai piedi del Colle del Sole, che corrisponde all’ l’attuale P.za
IV Novembre, incrociavano le due vie principali della città, il cardo
maximus, che salendo dall’Arco di Augusto per l’attuale via U.
Rocchi, attraversava la piazza e continuava, con un percorso che doveva
coincidere con l’attuale Corso Vannucci, fino alla Porta Marzia, e il
decumanus maximus, che dalla porta Trasimena attraverso l’attuale via
dei Priori (dove recentissimi lavori per la manutenzione della rete telefonica e idrica hanno messo in
luce alcuni basoli), raggiungeva la zona centrale e proseguiva poi,
verosimilmente, per P.za Piccinino e Via Bontempi, fino a raggiungere l’arco
dei Gigli.
L’attuale assetto della
Piazza, caratterizzato dalla presenza di numerosi edifici sorti in gran
parte lungo un arco di tempo che va dal sec.XIII al XVII, in mezzo alla
quale spicca la splendida fontana dei Pisano, ha, naturalmente, molto
alterato la fisionomia che quest’area doveva presentare in età antica,
rendendo così ogni tentativo di ricostruzione difficile e, nella migliore
delle ipotesi, incompleto.
Tuttavia, alcuni studi e
poche fortunate scoperte, succedutesi lungo un arco di tempo considerevole,
hanno reso disponibile un certo numero di dati relativi a questo settore
della città antica che permettono di farsi comunque un’idea sull’aspetto che
doveva avere.
L’interesse per alcuni
resti antichi presenti all’interno del complesso della Cattedrale di
S.Lorenzo è evidente sin dal prima metà del sec. XVII, quando Felice Ciatti,
nelle Memorie annali et istoriche delle cose di Perugia, riferiva
che “si veggion nelle cantine de’Canonici del Duomo antichissime fondamenta
di grossissimi marmi quadrati…”; questa struttura, segnalata già da Cesare
Crispolti nella sua Raccolta delle cose segnalate, la prima guida
turistica della città, era stata interpretata come parte delle fondamenta di
un tempio identificato, sulla base di alcuni dei passi di Appiano e di
Cassio Dione relativi ai fatti del bellum Perusinum, con quello di
Vulcano o con quello di Giunone. La critica di fine ottocento-inizio
novecento scartò quest’ipotesi e preferì vedervi i resti di una cinta
interna alla città che doveva difendere l’Acropoli, identificata (questa sì
con sicurezza) con il Colle del Sole, in età ellenistica.
L’ipotesi più convincente sembra però
quella che scaturisce dagli ultimi studi che mostrano come il monumento non
siano altro che i che resti di una articolata struttura di sostruzioni
destinata a contenere la zona del foro verso la parte ONO (e di cui è
possibile vedere altri frustuli all’interno del Museo del Capitolo di S.
Lorenzo e della Pasticceria “Talmone”): i forti dislivelli altimetrici che
la città presenta, infatti, certo molto più evidenti in età antica,
dovettero, probabilmente, indurre gli antichi abitanti a organizzare la
città su un sistema di terrazzamenti allo scopo di rendere più agevole la
circolazione e di guadagnare spazi da destinare ad aree pubbliche, come il foro, secondo un
modello di chiara derivazione ellenistica, che trova nella situazione
urbanistica di Assisi il confronto più vicino.
Un altro ritrovamento molto interessante
fu quello effettuato in occasione di alcuni lavori di ripavimentazione che
interessarono P.za IV Novembre nel 1961, e ripresi poi nel 1979/80:
parallelamente alla fronte del Palazzo del Vescovado, nel lato O della
piazza, venne messa in luce una struttura (ora non più visibile) lunga circa
27 m. e larga 5 e con orientamento N-S, identificabile con una grande vasca
o una cisterna per l’approvvigionamento idrico. La struttura, realizzata in
opera cementizia, ha il fondo e le pareti rivestite in cocciopesto; oltre
che come cisterna, è stata anche interpretata come la vasca inferiore di una
fontana pubblica, posta in questa zona del foro a far da quinta
architettonica all’intera area.
Un altro manufatto, del
tutto simile al precedente fu rinvenuto nella medesima occasione lungo la
facciata dell’antica Chiesa di S. Severo di Piazza (ora inglobata nella
struttura di Palazzo dei Priori e difficilmente riconoscibile) orientato
ortogonalmente al precedente quasi a formare un angolo retto, ma le allora
esigenze di cantiere ne permisero solo un’esplorazione superficiale.
Scavi precedenti, eseguiti sul finire del
sec.XIX in relazione ai lavori di posa del nuovo acquedotto cittadino,
avevano messo in luce nel lato opposto, di fronte a Palazzo Friggeri,
un’iscrizione molto frammentaria, rinvenuta a circa 1.80 m. di profondità.
Il testo, molto frammentario e inciso su quattro righe su di una lastra di
marmo recita: Imp. Cae[…] / Perusini[…] / Ti. Claud[…] /
c[…].
Oggetto di vari studi,
l’epigrafe è stata interpretata anche in considerazione della
forma del supporto che richiama, inequivocabilmente, una struttura
architettonica, ora come ciò che restava di una dedica pertinente ad un
monumento equestre dedicato a Augusto dai Peursini per la
restituito della città dopo i fatti del 41-40 a.C. e situato nel
foro, ora come un’iscrizione menzionante un restauro (forse di un edificio,
vista anche la forma della lastra che sembra ricordare più quella di un
architrave) fatto eseguire da Claudio su un opera realizzata nella città da
Augusto.
Sulla presenza di altre
strutture o edifici nell’area del foro, che pure dovevano esistere per
garantire la vita civile e istituzionale della città, non si hanno finora
notizie certe; un’iscrizione, la CIL XI 1924, trovata nella piccola
chiesetta di S. Maria degli Aratri che sorgeva nei pressi della piccola P.za
Cavallotti (ora è la chiesina di S. Matteo in Campo d’orto, nei pressi del
complesso monumentale di S. Francesco al Prato), sembra segnalare ancora in
età antonina, l’esistenza della curia da ubicarsi, verosimilmente, nell’area
del foro e di una non altrimenti nota Schola Laeliana, mentre è
ancora molto dibattuta la pertinenza alla città di un’epigrafe, la CIL
XI 1946, rinvenuta, sembrerebbe, in località Canaglia e attestante una serie
di strutture tra cui il Comitium e un saliente la cui ubicazione, nel
caso in cui venisse verificata l’attinenza del documento alla Perugia
d’epoca romana, potrebbe proporsi sempre nella stessa area.
Da segnalare, infine, la
presenza alla base del campanile del Duomo di resti murari di incerta
lettura e molto rimaneggiati e di altri paralleli a questi inglobati, sul
lato opposto della piazza, nelle strutture di Palazzo dei Priori (visibili
all’interno del guardaroba del Bookshop della Galleria Nazionale
dell’Umbria) sui quali rimangono però ancora molte perplessità.
Lucio
Benedetti
|
|