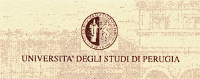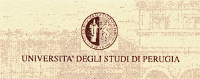| |
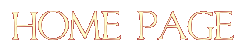

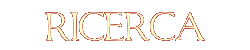



Cliccare sull'immagine per ingrandirla:
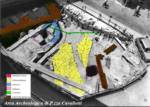

|
|
|
L’AREA
ARCHEOLOGICA DI PIAZZA CAVALLOTTI
Nell’inverno 1983-84, a seguito di alcuni lavori di ripavimentazione fatti
eseguire dal Comune nella piccola P.za Cavallotti, compresa tra P.za. IV
Novembre e P.za Morlacchi, venne alla luce un’importante area archeologica,
lo studio della quale ha fornito preziose informazioni per la conoscenza del
tessuto urbano d’epoca romana.
Gli
scavi, ai quali si accede tramite una botola che si trova direttamente sulla
piazza, hanno restituito parte dell’ incrocio di due strade (da mettere,
verosimilmente, in connessione con un tratto rinvenuto all’interno della
pasticceria “Talmone”, nella soprastante Via Maestà delle Volte, e con un
altro scoperto in un ambiente del capitolo della Cattedrale),
rispettivamente dirette una nella zona di P.za Morlacchi mentre l’altra,
seguendo l’attuale percorso di Via della Stella, si raccordava al
decumanus maximus, identificato con l’attuale Via dei Priori.
Il lastricato è formato da
grossi basoli e il tracciato conserva i margini laterali, anche se presenta
al centro delle lacune, dovute ad interventi realizzati nell’area già dagli
anni trenta, per permettere il passaggio di alcune tubazioni. Il tratto di
strada, che presenta un orientamento E-O, e che doveva prendere avvio
dall’attuale P.za Danti per passare poi sul lato settentrionale della
Cattedrale costeggiando l’imponente muro di sostruzione di Via delle Cantine
fino a P,zza Cavallotti, conserva anche parecchi solchi dovuti al passaggio
di pesanti carri; la ruderatio è costituita da scaglie di pietra,
frammenti di laterizi pressati e frammenti ceramici.
A N del selciato stradale
si è individuata una profonda cavità cilindrica, lo scavo della quale ha
restituito un unico strato di color grigiastro composto di carboncini misti
a diversi materiali, costituiti in gran parte da vasellame di piccole
dimensioni (unguentari, olpette, olle etc.), di ceramica acroma, piatti,
piccole lucerne a vernice nera, monete (alcuni assi di bronzo dell’età
repubblicana della serie onciale e sestantale con testa di Giano bifronte,
databili tra il 286 e il 268 a.C.), basi di colonna e altri elementi
architettonici, che sono databili tutti tra il III e il I sec. a.C. Il fatto
che la cavità sia stata rispettata dalla costruzione della strada, ha fatto
supporre una sua destinazione a scarico votivo nei pressi di un area sacra,
di cui purtroppo non si hanno notizie anche se recentemente è stata messa in
connessione con quella che doveva trovarsi intorno all’ara di Silvano,
menzionata in un’iscrizione proviene dalla vicina Via del Verzaro.
Sul lato S invece, gli scavi hanno messo
in luce un complesso sistema di canalizzazione e i resti di una struttura a
pianta semi-ellittica che le indagini hanno rivelato avere due fasi distinte
di costruzione: la prima è costituita da un ambiente di
forma semicircolare, delimitato da una muratura a filari piuttosto regolari
di blocchi di calcare locale legati da malta e da un pavimento in marmo
grigio, come lascia pensare il trovamento di alcune crustae marmoree
sulla parete di fondo. All’interno, inoltre, è stata rinvenuta una
fistula aquaria, conservata per una lunghezza di circa 2,10 m., e che
presenta un’iscrizione su due lati recante il nome del plumbarius:
Iucundus Lani Fort(unati).
Questi dati, unitamente
allo studio dei materiali rinvenuti all’interno della struttura stessa,
hanno fatto ipotizzare che si tratti di una fontana costruita intorno ai
primi due secoli dell’età imperiale e che si trova in stretta connessione
con le canalizzazioni a cui si accennava.
Successivamente, verso il
V sec. d.C., la fontana subì l’ampliamento e l’allungamento delle murature
perimetrali mediante interventi realizzati con una tecnica molto simile a
quella adottata per la fase precedente, ma con l’uso di pietre di dimensioni
maggiori. Dopo l’ampliamento, la struttura venne interamente ripavimentata
con grandi tessere di mosaico di color rosa e delimitata, sul lato prossimo
alla strada, da canalette di travertino per lo scolo dell’acqua.
Lo studio dei cunicoli
rinvenuti all’interno del complesso, infine, ha mostrato come questi
facessero parte di una rete più ampia che serviva verso E l’odierna Piazza
Morlacchi, mentre verso O la zona del foro, raccordandosi ad altre strutture
per l’immagazzinamento dell’acqua rinvenute proprio in quell’area.
Lucio Benedetti
|
|