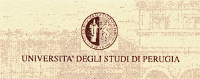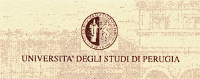| |
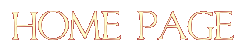




Cliccare
sull'immagine per ingrandirla:


|
|
|
L’ANFITEATRO
L’esistenza di antichi resti romani nei sotterranei di Palazzo della Penna
era nota almeno fin dal sec. XVII, quando cioè Felice Ciatti, uno dei primi
studiosi della Perugia antica, descrivendo in un passo delle sue Memorie
annali et istoriche delle cose di Perugia l’area che si trova
immediatamente fuori la Porta Marzia, riferendosi a quei ruderi ricorda come
in questa zona della città “è fama essere stato il teatro di cui alcune
poche reliquie credonsi esser rimaste nelle case dei Vibij, e se ne vede
qualche vestigio nello spatio sferico di un’antica fabrica, sopra la quale
dette case sono erette”.
Lo
stesso Ciatti, comunque, in un passo successivo della stessa opera afferma
che “l’amfiteatro…era già nella regione di [P.S.P], in quella parte ove ora
sono le case dei Vibij, del che sino al giorno d’hoggi si vedon chiari
vestigij, e restò in piedi fino alla venuta de’Goti, contro i quali servì
quasi per Castello, e per Fortezza.”
L’interesse per questi antichi “vestigij” aumentò notevolmente nei secoli
successivi e mentre il Crispolti e il Siepi non esitarono a vedervi ciò che
restava della struttura dell’anfiteatro romano, la confusione tra teatro ed
anfiteatro continuò ad essere presente anche nell’opera di altri illustri
studiosi di antichità locali come il Bonazzi e il Santi.
Il restauro di Palazzo della Penna,
avvenuto intorno agli anni ottanta, ha nuovamente riportato l’attenzione su
queste persistenze, permettendone un’analisi molto più puntuale e corretta
che ha definitivamente appurato la pertinenza delle stesse alla struttura di
un anfiteatro. I sopralluoghi iniziali hanno rilevato come i resti
conservati siano costituiti da frustuli di una struttura muraria situata
allo spiccato delle pareti del palazzo attuale, disposta lungo un corridoio
anulare che percorre l’edificio in tutta la sua lunghezza. L’andamento del
muro antico è visibilmente inflesso e accompagna con esattezza la curvatura
del corridoio di cui costituisce, per un lungo tratto, la parete interna.
Si tratta, insomma, di una
struttura in opera cementizia, che presumibilmente costituisce il resto di
un nucleo centrale di un muro dotato di un paramento esterno. Lungo il muro
si schiudono aperture antiche, corrispondenti alle aperture di Palazzo della
Penna. È probabile che si tratti della fronte esterna di una delle gallerie
periferiche.
La lunghezza della parte
conservata è di circa 35 m., mentre la larghezza varia dagli 80 ai 150 cm.;
per l’altezza si arriva ad un massimo di 3.20 m. e il raggio della curvatura
visibile è di circa 54 m.
La ricostruzione
dell’intera curva produce un’ellisse con diametri pari a 60 e 80 m., anche
se queste cifre possono contenere consistenti margini di errore, visto la
frammentarietà della struttura conservata. In fondo alla parete del
sotterraneo più settentrionale, è stata inoltre rilevata la presenza di una
nicchia in opus vittatum indicante, probabilmente, la posizione del
lato corto di un ambiente cuneiforme di sostegno della cavea, e questo fatto
potrebbe consentire di conoscere la posizione del podium e dell’euripus,
e quindi anche quelle dell’arena, le cui dimensioni dovrebbero aggirarsi
intorno a i 45 x 26 m.
E’ probabile comunque che
il perimetro sopra ricostruito non costituisca esattamente il margine
esterno dell’anfiteatro, e in questo caso la struttura avrebbe potuto
estendersi più a valle, fino al limite sud-est di Palazzo della Penna, ma al
momento non vi sono dati per dimostrarlo.
Sfortunatamente la
mancanza di resti della parte a monte e l’attuale sistemazione urbanistica
di quest’area, impedisce di sapere se l’anfiteatro fosse interamente
costruito o se, verso le mura urbiche, fosse appoggiato ad un terrapieno.
L’esiguità e lo stato
attuale delle strutture conservate, infine, non permettono di fornirne una
datazione precisa: è probabile, comunque, che esso, unitamente forse ad
altre strutture, fosse compreso in un progetto più ampio, concepito in
seguito ai fatti del bellum Perusinum e promosso da Ottaviano stesso,
teso a ridisegnare il profilo urbanistico dell’intera città.
Lucio Benedetti |
|